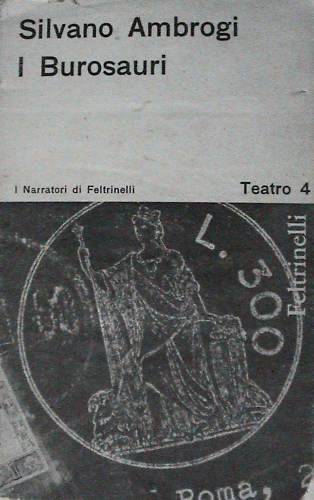Gli egosauri
di Pier Aldo Rovatti
Questi strani animali che stiamo tutti diventando forse un giorno si estingueranno e i posteri cercheranno di capire come eravamo fatti, come siamo sbucati fuori e che cosa è successo dopo. Forse. Chissà quando. Non necessariamente.
Li battezzerei “egosauri” perché sono animali mostruosi con un corpo eccessivo, pesante, lento, inutile: un corpo che non è più davvero tale e la cui mostruosità corrisponde a una sproporzionata superfetazione dell’“io”. Nietzsche aveva immaginato umani che perdevano le loro fattezze per trasformarsi in un unico e mostruoso orecchio: leggendo adesso queste fantasie ci limitiamo a sorridere come di fronte a un curioso divertimento letterario.
Così come leggiamo con leggerezza le parole caustiche di Gadda quando scrive che l’io è il più orrendo dei pronomi. Però gli egosauri sono attorno a noi e ormai dentro di noi, eccoli qua senza ricorrere alla fantasia, realissimi, poco divertenti, senza pedigree letterario, non traducibili in alcuna urticante morale. Siamo noi, nella nostra normalità, ovvia e generalizzata: degli io sempre più enormi che vagano sul pianeta terra con un unico scopo, diventare ogni giorno più gonfi di sé.
Dietro la parola egosauri, che propongo al lettore, agiscono nella mia mente un paio di risonanze del tutto personali, non so quanto interessanti. Relais bizzarri come il rimando a una vecchia commedia di Silvano Ambrogi messa in scena a Milano dal titolo I burosauri: il personaggio principale (interpretato da Ernesto Calindri) era perfetto nel ruolo del burocrate assillato, anzi “oberato” dalle sue pesanti scartoffie. Una gag che non riesco a dimenticare. Questo burocrate, antiquato e immobile, si attagliava perfettamente a una specie di dinosauro già quasi estinto, tuttavia destinato a restare ben piantato nella società contemporanea.
Il mio secondo relais mi sposta un poco più avanti a una canzone di Giorgio Gaber che in modo tambureggiante annunciava che i tecnocrati, animali notturni e pronti a prendersi tutto, avevano ormai circondato le città e stavano occupando i luoghi del potere. Qui l’atmosfera è opposta alla precedente: niente polvere o lentezza, ma sagome nere che scattano felinamente nell’ombra. Saranno loro, cantava Gaber, a occupare le nostre vite.
Che strano, direte, sovrapporre l’immagine del burocrate incartapecorito e con i gomiti rinforzati perché lo star lì alla scrivania non consumi le sue maniche, agli scatti rapidi di chi arriva con la pretesa di prendere per sé ogni cosa. La seconda immagine corrisponde a quegli io affamati di potere in cui è facile identificarci. La prima richiama la sconsolante passività di chi inclina verso la stasi.
Eppure mi pare di riconoscere i dinosauri in entrambe le scene: insomma, quello che mi galleggia nella mente è un mix abbastanza inquietante tra due immagini che mi servono per raffigurare un essere mostruoso che ancora non conosciamo ma che ha tutta l’apparenza di un ibrido paradossale, insieme lentissimo e velocissimo, contraddittorio.
L’io e l’ego sembrano termini intercambiabili, a misura che preferiamo un vocabolo domestico appartenente al discorso comune, per quanto denso di implicazioni teoriche e di aggiustamenti storici, oppure desideriamo pescare dalla lingua latina una parola più austera e meno usata. È solo per evitare un effetto cacofonico che potremmo chiamare egosauri i curiosi animali nei quali ci stiamo metamorfizzando? Potremmo dire di sì per non complicare eccessivamente la scena. Ma, a guardar bene, io ed ego indicano anche delle diversità.
Egoismo ed egocentrismo, per esempio, sono caratterizzazioni che spostano un poco il senso dell’intera questione, come se dicendo ego, o qualcuno dei suoi derivati linguistici, conferissimo un più di autorevolezza alle parole che pronunciamo e quindi anche agli animali mostruosi che sto evocando.
Convochiamo per un momento il pensiero di Freud, nel quale la lunga e travagliata vicenda del pronome io trova una sua sistemazione, quella a cui tutti ci riferiamo oggi quando nella comune discorsività adoperiamo la prima persona. A nessuno verrebbe in mente di sostituire io con ego. Ma in cosa consiste questo gettonatissimo io di cui ci riempiamo la bocca? Esso è soprattutto volatile. Più lo mettiamo in gioco, più ci esponiamo alla sua vulnerabilità. L’io è un operatore individuale, esposto a ogni friabilità, pronto a disfarsi. L’io assomiglia infine a qualcosa di liquido che ci scappa via da ogni parte.
Freud e la migliore psicoanalisi che ne ha raccolto l’eredità (penso a Lacan soprattutto) sanno perfettamente che l’io nel suo isolamento è una sorta di illusione o di ideale fallace da smascherare, e anche se si tratta di una parte mai cancellabile della soggettività di ciascuno è pur sempre una caratteristica parziale che non può colonizzare l’intero territorio, farla da padrone assoluto.
Battaglia difficile, soprattutto battaglia culturalmente perdente se solo rivolgiamo lo sguardo a cosa sta accadendo in noi e attorno a noi. L’inconscio, che Freud alla fine chiamava Es, è scomparso dalla scena: resta come un fantasma che incute poco timore, come una caricatura irriconoscibile. Meglio: come una canzone da organetto che canticchiamo allegramente mentre esaltiamo in ogni modo il nostro io.
Così andiamo costruendo, senza soste né dubbi, traendo godimento dal continuo rimbalzo tra dimensione privata e dimensione pubblica, quella politica dell’“io prima di tutto” che attualmente esercita un incontrastato protagonismo sociale. E carichiamo il termine ego di un potere di spaesamento che vorrebbe depistare il semplice, troppo immediato narcisismo che pratichiamo ovunque e in qualunque momento. Come se volessimo bloccare e dare materialità alla volatilità dell’io, che non è opportuno professare apertamente, in un corpo straripante che ci procuri qualche sicurezza.
Ed eccoli, appunto, i bestioni che vorrei chiamare egosauri, forse già estinti ancor prima di esistere, oppure dotati di una parvenza di vita autonoma. Inganni viventi che si avanzano giorno dopo giorno, una solitudine di massa, senza neanche il bisogno di sgomitare. Occupano il territorio. Si ammassano sempre di più. Qualcuno emette latrati o stridii, ma non ce ne sarebbe la necessità poiché nessuno intende uscire dal gruppo, anzi via via molti seguitano a entrarci. Forse, se osservassimo bene, potremmo riconoscere anche noi stessi lì in mezzo.
[uscito su “L’Espresso”, 21 ottobre 2018]
Post
- Appuntamenti (19)
- Archivio (326)
- Articoli (40)
- Collaboratori (1)
- Discussioni (36)
- etica minima (75)
- Libri (11)
- pandemia (11)
- Promozioni (2)
- Rassegna stampa (8)
- Ultimo numero (1)